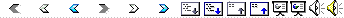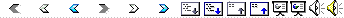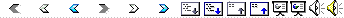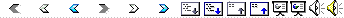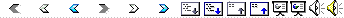|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A bordo di questo satellite è presente un
radiometro con tre canali che riprende la Terra in bande spettrali
differenti, dalle quali si ricavano le immagini |
|
nel visibile, |
|
nell'infrarosso e |
|
nel vapor d'acqua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Le immagini trasmesse dal METEOSAT, nella
rappresentazione equatoriale, vengono riproiettate secondo la stereografica
polare. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L’osservazione nella banda dei 10 µm è definita
in finestra poiché la radiazione non viene assorbita dall’atmosfera. Quindi
la radiazione osservata è quella emessa direttamente dai corpi condensati,
che emettono secondo la curva di corpo nero. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L’osservazione nella banda del visibile è in
finestra poiché la radiazione non viene assorbita dall’atmosfera. |
|
Quindi la radiazione osservata è quella solare e
riflessa dai corpi condensati. |
|
Pertanto le immagini nel visibile mostrano il
grado di riflettività del corpo osservato. |
|
|
|
|
|
|
Per l’interpretazione dei grigi si deve
considerare che la rappresentazione del canale visibile è in positivo
ovvero il bianco corrisponde ad alti valori di riflettività, il nero a scarsi
valori di riflettività. |
|
Secondo
la tabella 2 il mare si presenterà scuro, mentre le nubi si presenteranno
tanto più luminose quanto più spesse. |
|
Le immagini vengono accuratamente contrastate
per consentire una buona percezione degli oggetti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
L’osservazione nella banda dei 6.7 m è in
assorbimento, quindi la radiazione osservata dal satellite è quella
assorbita e riemessa dall’H2O presente nell’atmosfera. |
|
Tale procedimento è schematizzato dalla figura
1, dove lo strato indica la regione atmosferica da cui proviene il massimo
della radiazione osservata. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il prodotto è realizzato attraverso la
combinazione delle informazioni desunte dalle osservazioni del METEOSAT
della radiazione proveniente |
|
dalla finestra degli 11 mm |
|
e quella dalla banda in assorbimento dei 6.7 mm. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questo prodotto risulta utile ai fini
diagnostici in quanto consente di: |
|
individuare la circolazione in atto; |
|
individuare le strutture nuvolose presenti sulla
scena; |
|
determinare la tipologia della struttura
attraverso la morfologia della sommità; |
|
di associare la circolazione alle strutture
nuvolose; |
|
di seguire l’evoluzione della struttura nuvolosa
attraverso l’evoluzione della sommità e dell’area interessata ed attraverso
la modificazione della circolazione che l’alimenta. |
|
|
|
|
|
|
Nella figura sono individuati tre sistemi
nuvolosi, ciascuno associata ad una circolazione: |
|
il sistema 1 è una struttura che si avvicina
alla penisola Iberico e la sua genesi è legata ad una veloce saccatura che
trasla verso oriente. La struttura presenta una morfologia stratificata. La
massa scura retrostante la struttura indica la componente secca che segue
la perturbazione. |
|
Il sistema 2 è legato ad un'intensa circolazione
legata ad un minimo sulle coste africane che richiama aria caldo umida sul
Mediterraneo. Il sistema presenta intensi sistemi convettivi. La tonalità
dei grigi evidenzia la circolazione ciclonica in atto che alimenta la
perturbazione. |
|
Il sistema 3 presenta una vasta area
stratificata bassa all'interno di una regione dominata da un vasto
promontorio, identificabile dalla massa scura. |
|
|
|
|
|
|
|
|
INTRODUZIONE: |
|
Il radiometro a bordo dei satelliti polari della
serie TIROS si chiama Advanced Very High Resolution Radiometer e possiede 5
canali (vedi tabella 1). |
|
Per motivi operativi vengono disseminate
soltanto le immagini elaborate a partire dai canali 2, 3 e 4. |
|
A partire dal NOAA 15 è stato introdotto
il canale 3a che opera, al posto del 3b, durante le ore diurne.
Tabella 1 |
|
Canale frequenza Regione spettrale Risoluzione |
|
1 0.6 mm Visibile 1 km |
|
2
0.8 mm Visibile 1 km |
|
3a 1.6 mm Visibile 1
km |
|
3b 3.7 mm Infrarosso 1
km |
|
4 10.8 mm Infrarosso 1 km |
|
5 11.2 mm Infrarosso 1 km |
|
|
|
Pertanto le immagini nel terzo canale
realizzate a partire dai dati dei NOAA 15,16,… saranno realizzate con i
dati del 3a o 3b a secondo che sia giorno o notte. Per i satelliti NOAA 12
e 14 è disponibile sempre e soltanto il 3b. |
|
|
|
|
PRESENTAZIONE DELLE IMMAGINI: |
|
La nuova veste grafica delle immagini TIROS ,
nei canali infrarossi 3b e 4, è realizzata attraverso una curva di
contrasto che lega i valori della temperatura T ai grigi G dell’immagine,
attraverso la relazione G(T) riportata in figura 1. |
|
|
|
|
GEOREFERENZIAZIONE: |
|
La georeferenziazione è la procedura che
consente di referenziare i dati (in questo caso i pixel dell’immagine)
rispetto ad un sistema di riferimento noto. |
|
In particolare l’obiettivo è associare correttamente
ad ogni elemento dell’immagine la relativa coordinata geografica. Per
eliminare l’errore di posizionamento insito nei dati del TIROS è stata
realizzata una procedura che riduce l’errore ad 1 km. |
|
Questa procedura utilizza i punti noti sulla
scena (linee di costa, fiumi, …), pertanto tale procedura di correzione non
viene realizzata in presenza di una scena completamente nuvolosa. |
|
|
|
|
|
INFORMAZIONI SULLA BANDA 3.7 µm: |
|
La banda dei 3.7 µm è una finestra in cui si
osserva sia la componente di radiazione solare sia la componente della
radiazione terrestre. |
|
Pertanto le immagini notturne forniscono
informazioni circa la radiazione emessa dalla superficie terrestre, mentre
le immagini diurne mostrano il contributo complessivo della radiazione
riflessa e di quella emessa dai corpi condensati osservati. |
|
Poiché la componente solare prevale rispetto a
quella terrestre le immagini diurne possono essere considerate un indice di
riflettività degli oggetti osservati. |
|
La rappresentazione pittorica tiene conto di
queste differenze pertanto: |
|
Le immagini notturne si presentano come un
infrarosso normale (le aree chiare corrispondono alle zone fredde,
mentre quelle scure corrispondono ai settori caldi). Questo tipo di
rappresentazione è denominata positiva (+) perché associa ad alti valori
del segnale (cioè alta temperatura) il nero e viceversa associa segnali
bassi (temperature fredde) il bianco. |
|
Le immagini diurne sono presentate all’inverso
(-)rispetto le precedenti, quindi in nero sono mostrati bassi valori di
segnale ricevuto, mentre in chiaro valori elevati. |
|
|
|
|
PROPRIETA’ DELLE IMMAGINI DIURNE (-) |
|
Le aree ghiacciate (cirri, neve al suolo)
e le nubi con gocce molto grandi appaiono scure. Infatti Nella banda
dei 3.7 µ il ghiaccio e le gocce d’acqua (al di sopra dei 10 µm) sono molto
assorbenti, pertanto la radiazione da esse scatterata è minimina Questo tipo
di informazione consente di individuare nelle strutture nuvolose le aree
con presenza di ghiaccio o con gocce precipitanti. |
|
Le ombre delle nubi, come nel visibile, appaiono
scure. Quindi i corpi ghiacciati presentano un’area più estesa rispetto le
immagini nel visibile (canale 2). |
|
Le nubi composte da gocce d’acqua mostrano varie
tinte in accordo con le dimensioni delle gocce (più sono grandi e più sono
scure). Questo consente di individuare le aree dove la nebbie è in
fase dissolvimento. |
|
In particolari condizioni il mare è molto
riflettente (SUN GLINT). Questa circostanza si verifica quando l'angolo di
osservazione del satellite è simile a quello di incidenza del raggio
solare. Il fenomeno del sun glint si presenta come una macchia bianca
attorniata da una vasta areola luminosa. |
|
|
|
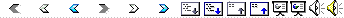
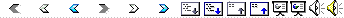
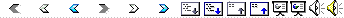
 Note
Note